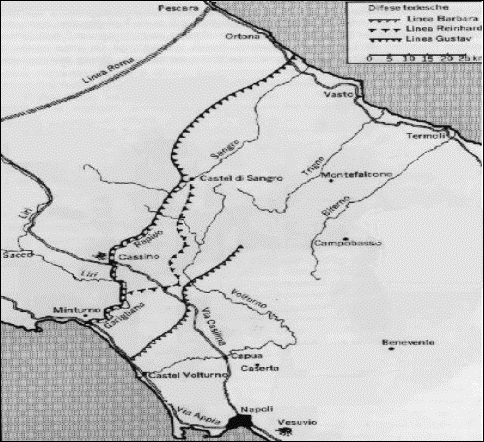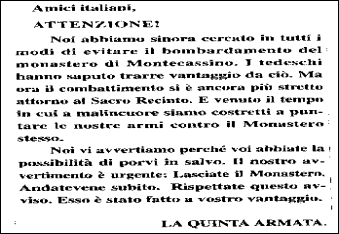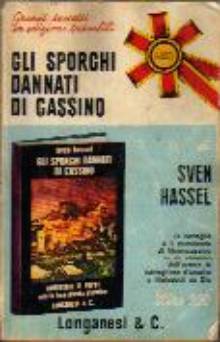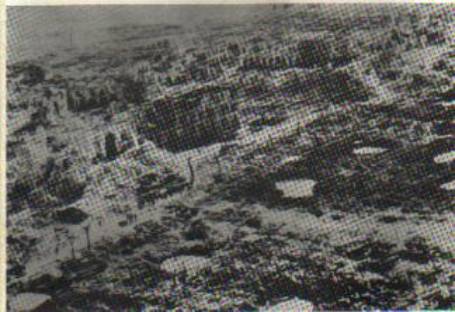La battaglia di Montecassino
di Gianni Sarro

PROLOGO
Il primo settembre del 1939 la Germania invadeva la
Polonia: era l’atto conclusivo di una strategia politico – militare
inaugurata dai tedeschi nel 1933, anno della presa del potere da parte di
Adolf Hitler, mirante a trascinare l’Europa sotto il dominio nazista. A
fianco dell’alleato germanico l’Italia di Mussolini entrò in guerra circa
un anno dopo: il 10 giugno del 1940. La guerra dell’Italia fascista durò
poco più di tre anni, fu segnata da cocenti sconfitte in Grecia, Africa e
dalla tragica spedizione dell’ A.R.M.I.R. in U.R.S.S. La situazione
precipitò con lo sbarco alleato del 10 luglio 1943 in Sicilia a cui fece
seguito la destituzione da parte del Gran Consiglio del fascismo e l’arresto
( quest’ultimo voluto dal Re) di Mussolini il 25 luglio. Infine, l’8
settembre veniva reso noto l’armistizio con gli alleati firmato tre giorni
prima, il 5, dal maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, nuovo primo ministro.
Ed è all'indomani della firma dell’armistizio che iniziò la vera tragedia
della guerra per la popolazione civile italiana: l’esercito si dissolse e il
Re con il governo fuggirono a Brindisi. I Tedeschi impiegarono pochi giorni a
impossessarsi del controllo della penisola, dalle Alpi a Napoli, non ancora
liberata dagli alleati. I due anni che seguiranno saranno durissimi, nulla
sarà risparmiato agli Italiani: da un lato i bombardamenti a tappeto da parte
degli anglo – americani, dall’altro l’occupazione feroce dei Tedeschi,
costellata di eccidi, rastrellamenti, privazioni di ogni tipo.
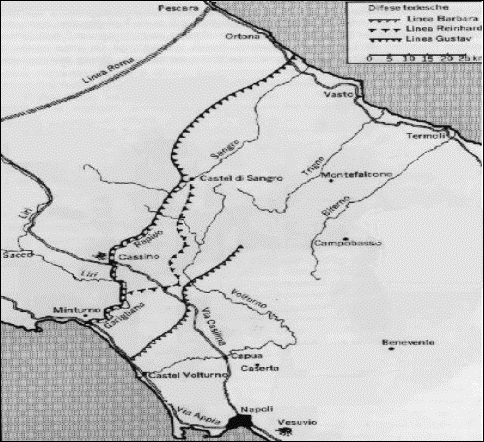
Il FRONTE SI FORMA A CASSINO
Una delle storie più tremende della guerra in Italia la
visse Cassino e tutta la Ciociaria, completamente sconvolte dai
sanguinosissimi combattimenti tra gli Alleati e i Tedeschi. Gli alleati il 9
settembre del 1943 sbarcarono a Salerno. Il 10 settembre iniziava il primo
bombardamento su Cassino, che rimarrà sotto le bombe degli aerei e dell’artiglieria
per 8 mesi quando verrà liberata dagli alleati, ormai ridotta a un cumulo di
macerie. I tedeschi fecero sfollare Cassino, per prepararvi meglio la loro
difesa. In questa fase la parte del leone la fece la R.A.F., l’aviazione
inglese, che era padrona assoluta dei cieli italiani. La popolazione non
intuì che stava per iniziare un lungo calvario: il 28 settembre, mentre
Napoli stava per essere liberata, su Cassino si abbatté uno dei più violenti
bombardamenti della guerra. Quel giorno i Tedeschi avevano rastrellato una
sessantina di civili e li avevano portati alla stazione ferroviaria a
scaricare fusti di benzina: appena videro le formazioni dei bombardieri
alleati comparire nel cielo, i soldati scapparono in alcuni depositi da dove
tenevano sotto tiro con i loro fucili i civili, i quali rimasti immobili sotto
il bombardamento morirono quasi tutti; solo sei o sette di loro si salvarono.
Intanto l’8 settembre, dopo l’annuncio dell’armistizio,
i tedeschi avevano preso il controllo della città, quasi senza trovare
resistenza, se non a porta S. Paolo. Hitler decise di affidare il comando
delle armate del Sud- Ovest a Kesselring. Questa nomina avvenne il 21 novembre
del 1943 e fu una grande sorpresa: infatti fino all’ultimo momento questo
incarico sembrava dover essere ad appannaggio di Erwin Rommel. Cosa era
successo? Pare che quest’ultimo fosse convinto della necessità, per i
Tedeschi, di abbandonare il sud Italia e attestarsi nel nord, per proteggere
meglio i confini del Reich. Kesselring da parte sua aveva il gran merito di
aver saputo far sganciare il grosso delle truppe tedesche dalla Sicilia e
portarle in salvo, dopo lo sbarco alleato sull’isola. Inoltre era molto
abile nella strategia della guerra di posizione e di logoramento: assicurava
quindi a Hitler quello che lui voleva, vale a dire fermare al più presto l’avanzata
degli alleati, tenendoli bloccati il più a lungo possibile nel sud della
penisola, in attesa di tempi migliori per i Tedeschi. Infine era stato sempre
Kesselring a prendere velocemente il controllo di Roma. Uno dei primi ordini
impartiti da Kesselring, quando ancora non era stato nominato comandante, fu
quello di resistere sulla linea del Volturno fino al 15 ottobre agli attacchi
della Vª Armata alleata: questo per avere il tempo di completare la linea
Gustav, che sarebbe dovuta essere il perno inespugnabile della linea di difesa
tedesca. Il motivo della decisione dei Tedeschi di attestare il fronte intorno
a Cassino va ricercato nella conformazione del territorio che va da Roma a
Napoli, la cui natura è caratterizzata da una serie di rilievi valicabili
soltanto attraversando strette strisce di terra. All’epoca l’ unica strada
interna atta al passaggio di truppe motorizzate era la statale n°6 ovvero la
Casilina e Monte Cassino era la vera chiave di accesso per Roma. Lì infatti
la valle del fiume Rapido forma un angolo retto con la valle del Liri e
consente a chi ne avesse tenuto il possesso di dominare entrambe le valli per
chilometri, quindi tenere Monte Cassino significava controllare la via
Casilina. I tedeschi avevano trasformato il monte e tutta la zona circostante
in un immenso bunker, disseminando ovunque postazioni di cannoni, piazzole per
nidi di mitragliatrici, ricoveri in caverna e campi minati lungo le rive dei
fiumi e i fianchi del rilievo montuoso. Infine non va dimenticato che questo
è il punto più stretto della penisola tra il Tirreno e l’Adriatico: i
tedeschi quindi decisero di costruire tre linee difensive parallele, distanti
12 – 18 km l’una dall’altra:
1. la linea REINHARD che andava dalla foce del Garigliano
fino all’Adriatico sul fiume Sangro;
2. la linea GUSTAV lungo il corso dei fiumi Liri e
Garigliano
3. la linea SENGER – RIEGEL ( meglio nota come Hitler)
che correva sulla direttrice Pontecorvo – Aquino – Piedimonte San
Germano.
La battaglia di Cassino fu una delle più sanguinose e dure
che si svolse nel teatro di guerra europeo. Gli alleati impiegarono otto mesi,
dai primi bombardamenti su Cassino del settembre ’43 fino all’ultima
offensiva del maggio ’44, per sfondare le linee tedesche. Il 22 gennaio 1944
gli alleati effettuarono anche uno sbarco ad Anzio, ma non seppero
approfittare del momentaneo sbandamento dei Tedeschi, finendo impantanati
anche sul litorale laziale. Quando all’inizio di gennaio del ’44 gli
alleati sferrarono la prima possente offensiva contro i Tedeschi, i due
eserciti si fronteggiavano così schierati:
-ALLEATI-
a) 5° Armata al comando del Generale Mark Clark
·
X
C.A. britannico sul Garigliano;
·
II
C.A. americano sul Rapido dinanzi alla piana del Liri, a Cassino e a Caira;
·
Corpo
di spedizione francese ( formata da contingenti di soldati marocchini e
algerini) sull’alto Rapido e in corrispondenza della valle del Rio Secco;
·
VI
C.A. (formata in prevalenza da divisioni americane e britanniche) nelle zone
di Salerno e Napoli;
·
La
riserva d’armata, in cui era presente anche un raggruppamento motorizzato
del collassato esercito italiano.
b) 8° armata al comando di Sir Oliver Leese
·
XXXI
C.A. (formata da divisioni britanniche e indiane) sull’alta e media valle
del Sangro;
·
V
C.A. ( paracadutisti canadesi e contingenti indiani) nella bassa valle del
Sangro;
·
Riserva
d’Armata formata dalla 2° divisione neozelandese.
c) Riserva generale
·
I
C.A. canadese, 3° divisione ftr. polacca carpatica.
tedeschi
a) 10° armata sul fronte Garigliano – Cassino –
Sangro
XIV C.A., formato da contingenti corazzati, di fanteria e
da montagna , tra il Garigliano e l’alto Rapido;
LXXVI C.A., formato da gruppi alpini, di fanteria
semplice e paracadutisti, nella valle del Sangro.
LE TRE BATTAGLIE DI Cassino
Dopo aver martellato con i bombardamenti la zona di Cassino
per quasi quattro mesi, gli alleati decisero che era giunto il momento di
sferrare l’attacco con le truppe terrestri, per sfondare le linee tedesche e
arrivare finalmente a Roma. Qui va fatta subito una precisione sulla
numerazione delle battaglie per la presa di Cassino: per i tedeschi furono
tre, infatti subirono tre attacchi da parte alleata a partire dall’inizio
del 1944, il primo dal 17 gennaio al 18 febbraio, il secondo dal
15 al 23 marzo e il terzo e decisivo dall’ 11 al 20 maggio. Per gli
Alleati, invece, le battaglie sono quattro: infatti suddividono in due
distinte battaglie quella dal 17 gennaio al 18 febbraio. Questo perché mentre
dal 17 gennaio al 7 febbraio furono le truppe Anglo – Americane della Vª
armata a combattere i Tedeschi, dall’ 8 febbraio andò a combattere a
Cassino l’VIIIª del gen. Freyberg composta da soldati Neozelandesi e
Indiani. Abbiamo adottato la numerazione tedesca evidentemente non per
simpatia, ma perché nell’attacco sferrato dagli Alleati nel periodo gennaio
febbraio non ci fu una soluzione di continuità dell’offensiva, ma piuttosto
un’ avvicendamento di truppe tra le loro fila : appare quindi congruo
parlare di te battaglie di Cassino.
LA PRIMA BATTAGLIA (17 gennaio – 7 febbraio)
- Il primo
attacco alla fortezza naturale di Cassino venne sferrato alle 9 di sera del 17
gennaio dal X corpo d’armata britannico insieme al II corpo d’armata
americano: la forza d’urto dell’offensiva alleata fu così forte che il 18
si profilò il crollo di tutto il fronte di Cassino. Per parare il colpo il
feldmaresciallo Kesselring richiamò in tutta fretta buona parte delle sue
riserve a contrapporsi agli Angloamericani. Furono quindi richiamate due
divisioni di Panzer Grenadier ( la 29ª e la 90ª) e alcuni contingenti della
Divisione Herman Göring
che riuscirono
a respingere l’offensiva. La prima battaglia per la conquista di Cassino
entrò nel vivo il 20, quando la 36ª divisione americana attaccò i Tedeschi
cercando di guadare il fiume Rapido: l’offensiva fu un sanguinoso fallimento
e i due reggimenti di punta furono quasi annientati. Le perdite della 36ª
divisione furono così ingenti da essere considerato uno dei maggiori disastri
per l’esercito americano dopo l’assalto subito dai Giapponesi a Pearl
Harbour. Nel frattempo il 22 gli alleati diedero inizio all’operazione Shingle
(tegola di legno), e cioè allo sbarco di Anzio. Lo scopo di Shingle fu
quello di tagliare le principali linee di comunicazione dei tedeschi nei Colli
Albani e di colpire alle spalle il 14° corpo d’armata tedesco. Lo sbarco
del 6° corpo d’armata del Generale Lucas tecnicamente riuscì, ma quello
che per Churchill doveva essere un "gatto selvatico" divenne,
(usando sempre le parole del primo ministro britannico) "una balena
arenata". Successe infatti che i tedeschi ancora una volta reagirono con
una prontezza impressionante, e pur disponendo di meno soldati e meno
materiali andarono vicinissimi a ributtare in mare gli Alleati. Questo
comportò che anziché essere aiutati dal 6° corpo le forze di Mark Clark
dovettero sferrare un nuovo attacco alla linea Gustav, questa volta da nord di
Cassino, per evitare l’annientamento della testa di ponte di Anzio. Così il
24 gennaio la 34ª divisione americana, appoggiata sul suo fianco dal corpo di
spedizione francese (formato per lo più da effettivi marocchini e algerini)
attaccò nuovamente Cassino, cercando di penetrarvi da nord est. I Tedeschi
resistettero per una settimana, e solo il 29 gli Alleati riuscirono a occupare
il villaggio di Cairo. Per un attimo sembrò che la strada aperta dai Francesi
del gen. Juin potesse servire per puntare su Piedimonte San Germano e
Roccasecca, invece il 142° reggimento del gen. Ryder ripiegò verso sud,
direzione Monte Cassino. Questo perché gli Americani nutrivano una sorte di
ossessione nei confronti di Cassino e del suo monte, peraltro strategicamente
giustificabilissima come abbiamo visto precedentemente, ma in questo caso non
capirono che i Tedeschi per ora inespugnabili frontalmente (e cioè da
Cassino) avevano aperto un varco sul proprio fianco, che, se sfruttato,
avrebbe rappresentato un vero cavallo di Troia. Ma gli americani non ebbero l’istinto
per seguire l’abbrivio dello sfondamento laterale. Nonostante questo, il 5
febbraio, con un colpo fortunato, il 135° reggimento conquistò una
collinetta sita immediatamente sotto il monastero, ma il pronto intervento di
un contingente della 90ª Panzer Division e dei parà sventarono il colpo.
Sempre il 5 gli Alleati riuscirono a impossessarsi della Rocca Janula. Dopo
poco più di una settimana di aspri combattimenti la Vª armata era riuscita
ad assicurarsi una solida testa di ponte, ma le sue truppe erano esauste ed
inoltre nuovi rinforzi stavano giungendo al comandante tedesco Senger. Fu in
questo quadro che il 6 maturò il cambio della guardia sul fronte alleato e
gli Americani lasciarono il proprio posto al 2° corpo d’armata neozelandese
del generale Freyberg, formate da due divisioni che si erano distinte per la
loro combattività in Africa: la 2ª divisione neozelandese e la 4ª indiana.
L’ordine per Freyberg era di assaltare contemporaneamente Cassino da nord e
da sud – est.
Il BOMBARDAMENTO DELL’ABBAZIA
–
Per il 15 febbraio era fissata la data della ripresa dell’offensiva alleata,
ma prima di dar vita al nuovo attacco, sia il comandante della divisione
indiana Tuker, sia Fryberg si trovarono concordi su un punto: l’Abbazia di
Monte Cassino andava bombardata, gli alleati nutrivano al riguardo una vera e
propria psicosi. A ogni modo nessuno era sicuro che all’interno delle mura
del convento vi fossero né soldati tedeschi né il più piccolo posto di
osservazione. In effetti la Wehrmacht, con l’avvicinarsi del fronte, aveva
stabilito un cordone sanitario di 300 metri intorno al perimetro delle mura
dell’Abbazia, eppure la massiccia mole dell’Abbazia incuteva timore agli
Alleati. Di sicuro vi era un dato: una volta deciso di sfondare la linea di
Cassino frontalmente era necessario impadronirsi dell’altura del Monte
Cassino. Fu così che Tuker e Fryberg chiesero un pesante bombardamento dell’Abbazia,
in quanto necessario dal punto di vista militare. D’altronde se era vero che
nemmeno un Tedesco trovasse ricovero dentro l’Abbazia era pur vero che tutto
il Monte pullulava di soldati della Wehrmacht. La psicosi di Monte Cassino era
aumentata da una serie di cartelli che i Tedeschi avevano lasciato in giro,
che recitavano: " voi siete sotto l’osservazione del nemico, non siate
sciocchi". Oltretutto un aereo di ricognizione alleato sorvolando l’Abbazia
aveva asserito di aver visto sul Convento delle antenne radio, che invece
erano dei parafulmini….
La decisione di bombardare l’Abbazia era ormai presa
nonostante il parere contrario di Clark, che poi fu colui che, a malincuore,
dovette dare materialmente l’ordine del bombardamento. Il 14 gli Alleati
gettarono una pioggia di manifestini, in inglese e italiano, in cui
preannunciavano il bombardamento, questo per dar modo sia ai profughi sia ai
religiosi presenti nell’Abbazia di evacuare il convento.
Il conto alla rovescia era alla fine: la mattina del 15, in
una giornata meteorologicamente serena, sul cielo sopra l’ Abbazia si
presentarono 142 aerei B-17 , le temibili fortezze volanti e 82 bombardieri
medi B-25 e B-26 che sganciarono quasi 500 tonnellate di bombe esplosive e
incendiarie. Il bombardamento andò avanti quasi tutta la giornata; alla fine
dell’Abbazia era rimasto un cumulo di macerie, aveva resistito soltanto
parte delle mura perimetrali, il cui spessore aveva retto al bombardamento. I
civili morti durante l’operazione furono un numero variabile tra i 100 e i
300, infatti mai fu possibile stabilire con esattezza quanti sfollati
ospitasse l’Abbazia prima del bombardamento. Il risultato però non fu
quello sperato dagli Alleati infatti nei giorni 16 e 17 i ripetuti attacchi
della 5ª e 6ª brigata si infransero contro l’accanita resistenza dei
Tedeschi, ben protetti nei loro bunker (che non avevano minimamente risentito
del bombardamento…) e fornitissimi di bombe a mano. Alla fine il disastroso
bilancio alleato di questi attacchi fu la perdita di 40 ufficiali e 600
soldati, tra morti e dispersi. Ma ci fu dell’altro; i Tedeschi all’indomani
dell’ attacco aereo si sentirono autorizzati a servirsi in tutti i modi
delle rovine del Monastero, sicché le macerie si trasformarono in una sorta
di bunker naturali per i soldati della Wehrmacht: adesso sì che il Monte
Cassino era pressoché inespugnabile. Ne sfuggì ai tedeschi l’occasione di
fare propaganda: asserirono infatti che gli Alleati non avevano avuto rispetto
nemmeno dei luoghi di culto. Infine il 18 tentarono un attacco i Maori del
28° battaglione neozelandese, ma furono ineluttabilmente respinti dai
Tedeschi. Freyberg allora decise per la sospensione dell’attacco, rimandando
ai primi di marzo la ripresa delle operazioni.
Il bombardamento dell’Abbazia di Monte Cassino alla fine
si risolse in un clamoroso errore tattico e psicologico: il Monastero era
stato abbattuto ma Cassino non era stata presa, e i tedeschi avevano
rafforzato le proprie difese. La prima battaglia di Cassino quindi si concluse
con una sconfitta per le armate alleate: la porta per Roma
rimaneva, per ora, saldamente chiusa: con il catenaccio.
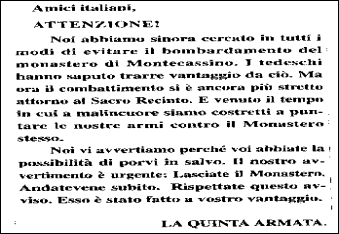
LA SECONDA BATTAGLIA (15- 23 marzo)
- Alexander,
Clark e Freyberg concertarono un nuovo attacco: questa volta l’offensiva
terrestre sarebbe iniziata solo dopo un bombardamento a tappeto di Cassino e
sarebbe stata ancora più diretta che in gennaio – febbraio. Freyberg
soprattutto era convinto che Monte Cassino sarebbe stata presa grazie a un
attacco dal basso, nella stesura dei piani di battaglia commise però un
errore: quello di non considerare che i Tedeschi avevano trasformato le rovine
dell’Abbazia in un vero e proprio fortino. Il piano, denominato operazione
Dickens, prevedeva di espugnare Cassino e la Rocca Janula con le truppe
neozelandesi, mentre gli Indiani avrebbero attaccato il Monte. Qualora fosse
arriso il successo alle due azioni sarebbe intervenuta la 78ª divisione
britannica. Il compito della 78ª sarebbe stato quello di attraversare il
fiume Rapido, ripercorrendo il cammino che tante perdite era costato alla 36ª
divisione americana durante la prima battaglia. Avendo il gen. Clark sollevato
delle obiezioni a questo piano, Freyberg stabilì che l’attacco a Cassino
sarebbe stato sferrato dalla 6ª brigata neozelandese e dalla 5ª indiana con
l’appoggio della 4ª brigata neozelandese. Appena si fosse aperta una
breccia sarebbe intervenuta il resto della 4ª divisione con un gruppo di
carri armati. Questo era il piano d’attacco sulla carta, la realtà dei
fatti fu purtroppo diversa.
L’attacco aereo fu rimandato fino al 15 marzo, dal
momento che, a partire, infatti dal 23 febbraio, per ventuno giorni nevicò e
piovve in continuazione, rendendo inattuabile qualsiasi attività aerea.
Continuarono invece di buona lena i martellamenti dell’artiglieria alleata.
Poi, preceduto dalla parola d’ordine " Bradman batte le mani", il
15 marzo 1944 alle ore 8.30 si presentarono sul cielo di Cassino 775 aerei
(575 bombardieri medi e pesanti e 200 tra caccia e caccia bombardieri) che
rovesciarono sulla città 1000 tonnellate di bombe. Alle 12.30 era tutto
finito, di Cassino, scomparsa sotto le bombe, non rimaneva praticamente più
niente, il panorama offriva solo macerie e immensi crateri. Immediatamente le
truppe alleate passarono all’offensiva, ma con loro immenso stupore furono
accolti dalle mitragliatrici tedesche. Un reduce anni dopo affermò: " i
tedeschi erano inspiegabilmente e ostinatamente vivi". La voglia di
combattere dei parà tedeschi del II battaglione del 4° reggimento
paracadutisti comandati dal maresciallo Nedhoff riuscì quindi a respingere il
primo attacco della fanteria alleata, per di più (come già era accaduto sul
Monte) i Tedeschi avevano tratto vantaggio tattico dal bombardamento, potendo
sfruttare le macerie come bunker. A ciò si aggiunga che i grandi crateri
scavati dalle esplosioni delle bombe risultavano degli ostacoli invalicabili
per i carri armati americani. Con uno sforzo immenso i Neozelandesi riuscirono
comunque a conquistare i due terzi di Cassino entro la sera del 15,
combattendo metro per metro. Ma inopinatamente quella stessa sera ricominciò
a piovere e la 4ª divisione indiana fu bloccata mentre stava per dare l’ultimo
assalto all’altura principale. Questo mutamento delle condizioni
metereologiche fu molto gradito dai Tedeschi che ebbero il tempo necessario
per far arrivare da Fontana Liri e Roccasecca l’11ª compagnia del 3°
Reggimento paracadutisti: l’ordine per il capitano Rennecke era quello di
resistere fino all’ultimo uomo. Il 16 e il 17 gli Alleati cercarono in ogni
modo di sfondare lungo la Casilina e soprattutto occupare il resto di Monte
Cassino. I tedeschi da parte loro cercavano in ogni modo di rimanere attaccati
a quella fettuccia di Cassino che era ancora in loro possesso per evitare lo
sfondamento del fronte. Nonostante l’impiego di carri armati i neozelandesi
non riuscirono a far sloggiare i paracadutisti di Heidrich dall’ Hotel
Excelsior che era il portale d’accesso alla strada statale. In compenso i
neozelandesi la sera del 17 riuscirono a occupare la stazione ferroviaria di
Cassino. Per il 19 era prevista un’altra spallata alleata in direzione dell’
Excelsior, ma Heidrich fu più svelto di Freyberg e lanciò i suoi
paracadutisti al contrattacco; Freyberg fu colto di sorpresa dalla
controffensiva tedesca, e decise di annullare l’offensiva. Anche sulle
pendici di Monte Cassino i Tedeschi resistevano a meraviglia: la mattina del
19 una fila di carri armati americani riuscì ad arrivare fin quasi alle
macerie dell’Abbazia, i Tedeschi in un primo tempo rimasero sorpresi, ma poi
reagirono con la loro consueta determinazione e distrussero nove carri armati.
Il 19, preso atto delle difficoltà incontrate dalle truppe
nel tentativo di sfondare le linee tedesche, i comandanti alleati
considerarono l’ipotesi di porre fine all'attacco per consolidare il terreno
conquistato in quei giorni che sarebbe stato utilissimo per l’offensiva di
primavera. Per gli Alleati era ora di vitale importanza riuscire a
disimpegnare i Gurka (truppe indiane) che, dopo l’arresto dell’offensiva,
erano rimasti isolati sui crinali della collina dell’impiccato, su per le
pendici del Monte Cassino. Per far questo furono fatti due sbarramenti di
artiglieria, cosicché i Gurka cominciarono a ridiscendere la collina. Ma la
storia non fu così semplice, infatti i soldati indiani a un certo punto
andarono a finire dritti verso una postazione di tedeschi, e vistosi perduti
decisero di farsi passare per feriti. Vi era infatti un accordo cavalleresco
(tra Wehrmacht e Alleati) secondo il quale si permetteva al nemico di
recuperare i feriti e riportarli verso le proprie linee: capitò per esempio
che i Tedeschi andassero a raccogliere i propri feriti e li potessero
trasportare grazie alle barelle degli Alleati restituendole poi il giorno
dopo. Ebbene i Gurka sfruttarono questa possibilità avvolgendosi in vistosi
bendaggi: badate che stiamo parlando di circa 400 uomini e i Tedeschi, che
proprio cretini non erano, al passaggio di uno degli ultimi gruppuscoli di
Indiani fecero sapere che da quel momento in poi avrebbero controllato l’entità
delle ferite…. Sia come sia, i Gurka si portarono in salvo e in questo caso
si può plaudire al barlume di umanità rimasto nell’inferno di quei
drammatici giorni.
Il 23 Freyberg decise per la sospensione dell’offensiva;
la seconda battaglia di Cassino combattuta tra anfratti, cantine, case
diroccate , cespugli era costata agli Alleati, secondo quanto scrisse
Churchill, 2400 uomini, quasi altrettanto ingenti furono le perdite per i
Tedeschi. Le truppe erano stanche e abbisognavano di riposo ( le due divisioni
neozelandesi furono smembrate) in attesa dell’ offensiva di primavera.
Sulla battaglia di Cassino è molto significativo ciò che
scrisse il Generale Alexander in risposta a un dispaccio inviatogli dal Primo
Ministro inglese Winston Churchill che gli chiedeva delucidazioni sul perché
" questa vallata -(quella del Liri) – rappresenti l’unico
fronte contro cui continuate a dar di cozzo. Ormai in questo settore si sono
logorate 5 o 6 divisioni". Alexander replicò così: " Lungo tutto
il fronte principale, dall’Adriatico alla costa tirrenica, soltanto la
vallata del Liri porta direttamente a Roma e offre un terreno adatto allo
spiegamento della nostra superiorità in fatto di artiglieria e di mezzi
corazzati. La grande strada statale denominata <<n.6>> è la sola
che dalle montagne dove ci troviamo si addentra nella valle. Lo sbocco nella
pianura è dominata dal Monte Cassino su cui sorge il monastero. Ripetuti
tentativi sono stati compiuti per aggirare il colle dell’Abbazia da nord, ma
sono falliti a causa dei profondi burroni, delle scarpate rocciose che
consentono la manovra soltanto a reparti relativamente piccoli di
fanteria". Alexander, sempre nello stesso messaggio a Churchill,
spiegava altrettanto precisamente anche il mancato conseguimento degli
obiettivi prefissatisi da Freyberg nella seconda battaglia di Cassino: "i
danni arrecati alle strade di Cassino dai bombardamenti furono così imponenti
che ne risultò gravemente ostacolato l’impiego dei carri armati e di ogni
altro mezzo da combattimento. La tenacia dei paracadutisti tedeschi è davvero
eccezionale, ove si consideri che sono stati sottoposti al più grande
concentramento di fuoco mai prima attuato, per ben sei ore, ad opera dell’intera
aviazione del Mediterraneo e di gran parte dei nostri 800 pezzi d’artiglieria.
Stento a credere che vi siano altre truppe al mondo che avrebbero potuto
resistere a tale tempesta di fuoco e poi passare all’attacco con la ferocia
da essi dimostrata". Questo carteggio tra Churchill e Alexander era
del 20 marzo 1944.
La situazione alla fine della seconda battaglia di Cassino
vedeva gli Alleati in possesso di quasi i ¾ della città, ma i Tedeschi
continuavano a controllare tutta la valle dal Monte. Per riprendere a
combattere gli Alleati aspettavano la primavera, quando si sarebbe sciolta la
neve sui monti e il terreno si fosse rassodato, cosicché avrebbero avuto a
disposizione un fronte più vasto per schierare forze ancora più ingenti di
quelle allineate da Freyberg.

LA TERZA BATTAGLIA ( 11 – 20 MAGGIO) –
Prima
di intraprendere la nuova offensiva, il generale Alexander riorganizzò tutto
il fronte Alleato, operazione che richiese circa due mesi di tempo necessario
affinché le truppe si riposassero dagli immani sforzi a cui erano state
sottoposte nei mesi precedenti. La nuova offensiva di primavera fu denominata
Diadem e prevedeva uno schieramento di truppe mai visto precedentemente sul
fronte di Cassino. Il piano d’attacco era stato preparato dal generale
britannico John Harding (uno dei più brillanti tattici dell’esercito di Sua
Maestà che in precedenza aveva architettato la difesa inglese nella battaglia
di Tobruk contro l’Africa Korps di Rommel), che aveva stabilito la
necessità di godere di una superiorità di fanteria quantificata in tre
uomini contro uno per avere qualche ragionevole speranza di aprire una breccia
nell’accanita linea difensiva tedesca. Harding calcolò che la forza d’attacco
alleata sarebbe dovuta essere di 12 divisioni, divise in 4 corpi d’armata:
due per sfondare il fronte e due per l’inseguimento dei Tedeschi. Infatti l’obiettivo
degli Alleati, una volta liberata Cassino, era quello di tagliare la ritirata
alle divisioni della Wehrmacht in modo tale da non doversele ritrovare davanti
nel proseguo della guerra. Alexander era in ogni caso convinto che gli Alleati
avrebbero tratto vantaggio, più che dal numero di divisioni a loro
disposizione, dallo stato di incertezza vissuto dai Tedeschi, che non
riuscivano a prevedere da dove sarebbe stato sferrato il nuovo attacco. In
effetti i Tedeschi non credevano molto all’ipotesi che gli Alleati avrebbero
cercato di sfondare il fronte di Cassino, visto che già due volte avevano
sbattuto il muso sulla linea Gustav. Gli Alleati avevano lasciato credere ai
Tedeschi di ritenere inespugnabile la Gustav, e quindi di ritenere necessario
un ulteriore sbarco a nord di Roma: con tutta probabilità a Civitavecchia.
Per rendere più credibile questa falsa notizia, gli Alleati avevano spostato
il corpo canadese, rinforzato dalla 36ª divisione U.S.A., nella zona tra
Napoli e Salerno, dove venivano addestrate le truppe alle tecniche anfibie.
Ovviamente l’ufficio informazioni degli Alleati non mancò di far sapere la
notizia ai tedeschi, i quali si fecero ingannare dal depistaggio degli
Alleati, che godettero anche di una circostanza fortunata: il Generale Senger,
convinto che l’attacco sarebbe avvenuto non prima del 24 maggio, si era
preso una licenza e si trovava in Germania ( singolare coincidenza con quanto
avverrà poco meno di un mese dopo in Normandia: il 6 giugno, giorno dello
storico sbarco, anche Rommel si trovava in Germania in licenza).
L’operazione Diadem era quindi articolata in tre fasi:
1. espugnare la linea Gustav, prima che Kesselring capisse
di essere stato aggirato dalla falsa minaccia dell’attacco anfibio a nord di
Roma;
2. la distruzione della linea Hitler (quella che andava da
Pontecorvo a Piedimonte), posta 10 km indietro rispetto alla Gustav, prima che
i tedeschi potessero trincerarvisi;
3. una volta sfondato il fronte tagliare le comunicazioni
della Xª armata tedesca all’altezza di Valmontone e di fatto farla
prigioniera.
Prima di sferrare l’offensiva gli Alleati dettero vita
all’operazione Strangle (che significa strangolare) che consisteva nel
bombardare a tappeto le comunicazioni terrestri nemiche affinché si
interrompessero, così da costringere i Tedeschi a ritirarsi per mancanza di
rifornimenti. In sei settimane Strangle provocò gravi danni: il traffico
ferroviario a nord di Roma fu bloccato dal bombardando degli snodi principali,
dei ponti e dei viadotti. Tuttavia i Tedeschi, per rimediare ai danni
provocati alla linea ferroviaria, trasferirono i rifornimenti sugli automezzi
facendogli viaggiare di notte. Strangle non si era però rivelata del tutto
inutile, infatti i rifornimenti tedeschi alla lunga si rivelarono
insufficienti per la lunga e aspra battaglia che gli attendeva.

Dopo tutte queste schermaglie intorno alle 23 dell’ 11
maggio, dopo che per tutta la giornata le artiglierie avevano stranamente
taciuto, gli Inglesi dell’ 8ª Armata sferrarono l’attacco sul Garigliano,
mentre i Polacchi del generale Anders attaccavano lungo i crinali a nord –
ovest di Monte Cassino, i Francesi di Juin sui monti Aurunci e gli Americani
di Clark sul fronte costiero. Lo spiegamento delle forze in campo sul fronte
lungo 30 km era portentoso: come auspicato dal gen. Harding gli Alleati
schieravano la bellezza di 16 divisioni contro le 6 della Wehrmacht,
appoggiate da circa 2000 cannoni e da circa 1000 aerei, mentre i Tedeschi non
avevano ancora completato le manovre difensive sul fronte di Cassino.
A ogni modo la mattina del 12, a una prima verifica dei
risultati ottenuti, gli Alleati constatarono di essere stati bloccati su tutto
il fronte: l’incubo dell’inespugnabilità della Gustav persisteva
tenacemente. Alle 14 del 12 fu bloccato l’attacco della divisione polacca
"carpatica" sul monte Calvario: essi avevano ingaggiato un furioso
corpo a corpo con i paracadutisti di Heidrich e, pur disponendo di un
soverchiante vantaggio numerico, i loro due battaglioni non riuscirono ad
avere ragione di 732 berretti verdi tedeschi. Questo ennesimo bagno di sangue
non fu però inutile: i Tedeschi per resistere alla violenta spallata dei
polacchi erano stati costretti a concentrarsi su Monte Cassino, allentando la
pressione sul fondo valle, dove gli Inglesi e Gurka Indiani ebbero tempo per
ampliare le teste di ponte. Lavoro necessario per permettere il passaggio dei
carri armati, di cui finalmente si poté fare largo uso, anche per le
favorevoli condizioni atmosferiche. Quindi i Tedeschi cominciavano finalmente
a cedere: il 14 le truppe marocchine del generale Juin, specializzate nella
guerra di montagna, (i famigerati Goumiers che si macchiarono di nefandezze,
come stupri indiscriminati e mutilazioni di cadaveri, che i Tedeschi mai
avevano perpetrato, perlomeno sul fronte cassinate) penetrarono lungo il corso
del Garigliano, occupando S. Ambrogio e S. Apollinare. Nel frattempo
Kesselring il 13 riuscì a far arrivare un'altra divisione al fronte, ma la
bilancia stava ormai pendendo dalla parte degli Alleati. Intanto gli Americani
della Vª armata avevano inferto un colpo mortale alle due divisioni tedesche
schierate a sud della Valle del Liri e fu lì che la linea Gustav cominciò a
sfaldarsi. Kesselring, allora, il 15 impegnò tutte le sue riserve a Cassino:
voleva ritardarne la caduta per poi ritirarsi dietro la linea Hitler. Ma gli
Alleati avevano attraversato in più punti il Garigliano e raggiunta in più
parti la Casilina (la famigerata statale n°6): Cassino aveva le ore contate.
Infine il 17 i Polacchi attaccarono per l’ennesima volta le rovine dell’Abbazia.
I soldati della 5ª divisione "Kresowa" puntarono la cresta del
fantasma e Colle S. Angelo mentre i "Cacciatori dei Carpazi"
cercavano di prendere Massa Albaneta e Monte Calvario: ancora una volta i
paracadutisti tedeschi reagirono con incredibile veemenza all’attacco.
Tedeschi e Polacchi combatterono all’incirca per dieci ore, le perdite
furono altissime da una parte e dall’altra, ma la battaglia era praticamente
finita: Kesselring informato che il corpo canadese era sul fronte di Cassino e
non a Salerno, dopo un serrato colloquio telefonico con von Vietinghoff
ordinò l’abbandono di Cassino e la ritirata sulla linea Hitler. I Tedeschi
si erano battuti fino all’ultimo, anche quando le sorti della battaglia
erano ormai segnate: della prima compagnia paracadutisti che per sei giorni si
era trovata nel centro del ciclone dell’offensiva alleata sul monte
Calvario, erano sopravvissuti un ufficiale, un sottufficiale e un soldato.

La mattina del 18 nessun tedesco era tra le macerie del
monastero, dove sventolarono gli stendardi delle truppe alleate che tanto
avevano combattuto in quei luoghi, contemporaneamente la 4ª divisione
britannica rastrellava Cassino: dopo 224 giorni dall’ 8 settembre era finita
l’occupazione tedesca. Ma nella zona i combattimenti continuarono, l’ultima
grande offensiva nella Valle del Liri fu lanciata il 24 dal contingente
canadese dell’8ª armata che puntò decisamente su Ceprano, i Tedeschi
comunque non erano in rotta, anzi la loro ritirata ebbe anche un certo ordine
e la 10ª armata riuscì a sfuggire alla cattura. Gli alleati arrivarono a
Roma il 4 giugno, ma l’aver perso l’occasione di chiudere in una sacca le
divisione tedesche fu un errore determinante, che farà protrarre la guerra in
Italia per un altro anno.
epilogo
– Alla fine di tutto di Cassino non restava più niente, nell’accezione
più letterale del termine. I bombardamenti aerei e i martellamenti delle
artiglierie prima, i combattimenti tra i soldati metro per metro poi, avevano
reso Cassino una zona desertica: era stata cancellata dalla cartina
geografica, nessun termine è tanto efficace quanto alcune immagini. In quella
epica e drammatica battaglia sul terreno rimasero i corpi di 22000 Tedeschi e
23000 Alleati : una carneficina.
Gli Alleati riuscirono a sfondare il fronte di Cassino
soprattutto grazie alle illimitate risorse degli Stati Uniti, la cui industria
poteva lavorare a pieno ritmo senza l’incubo di avere la guerra in casa.
Questo permise agli Alleati di poter sostituire in continuazione uomini e
mezzi e anche di rifornirli adeguatamente. A ciò aggiungiamo il fatto che gli
Alleati avevano il controllo completo dell’aria e del mare, quindi i
Tedeschi erano pressoché in trappola; la loro fine era segnata, eppure si
batterono con una tenacia e un valore encomiabile: i riconoscimenti che
provengono da Churchill, Clark e Alexander sono assolutamente non di parte. La
tragica follia e abnegazione di quei straordinari combattenti sfugge a
qualsiasi analisi. Avevano l’ordine di combattere e lo fecero fino a quando
hitler non si suicidò: la guerra finirà infatti dopo altri 11 atroci mesi di
guerra. La forza dei tedeschi fu il grande addestramento della sua fanteria,
la Wehrmacht, che combatté ostinatamente fino alla fine, e tra l’altro
riuscì a ritirasi in buon ordine, senza mai arrivare al collasso.
Strategicamente gli Alleati avevano puntato molto sugli
effetti dei bombardamenti a tappeto, questo nella speranza di rendere
inefficaci le difese tedesche e quindi di dover pagare un prezzo non troppo
alto in vite umane. Ma l’evoluzione delle tre battaglie non andò così,
anzi: i massicci bombardamenti produssero inopinatamente un vantaggio per i
Tedeschi, che abilmente trasformarono le macerie in trincee inespugnabili per
otto mesi, costringendo gli Alleati a combattere casa per casa e di
conseguenza a perdere molti uomini.
Si è scritto del valore dei soldati tedeschi; questo non
fa sicuramente dimenticare e passare in second’ ordine lo straordinario
comportamento delle armate alleate: Americani, Inglesi, Indiani, Neo Zelandesi
e Polacchi vinsero quella sanguinosissima battaglia grazie a una tenacia
eroica.
Montecassino, un nome, un monastero a metà dimenticato da
qualche parte a sud di Roma ? No, un inferno, così indescrivibile che neppure
l’uomo più ricco di fantasia saprebbe dipingerne l’orrore. Un posto dove
i morti muoiono cinque volte. Il paese della fame, della sete e della morte.
Un cimitero per giovani dai venti ai trent’anni. Che cos’è la cosa
peggiore? Il fuoco? La fame? La sete? Le baionette luccicanti, l’olio
bruciante dei lanciafiamme? O gli enormi topi grossi come gatti? Non lo so. Ma
quel che né io né gli altri combattenti di Montecassino dimenticheremo mai,
è la puzza. L’odore dolciastro di cadavere e di cloro; la puzza di
Montecassino.
Nove colonne su dieci di rifornimenti restavano preda della
morte. Si può mangiare la corteccia, le foglie, ma la sete! Ci battiamo come
bestie feroci attorno alla buca di una granata riempita d’acqua. Un branco
di topi beve golosamente. Lanciamo loro una bomba a mano per disperderli e,
senza aspettare altro, ci precipitiamo e beviamo, beviamo!
Questa è Montecassino , la montagna sacra.
(SVEN HASSEL – Gli sporchi dannati di Cassino).
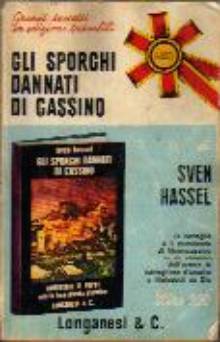
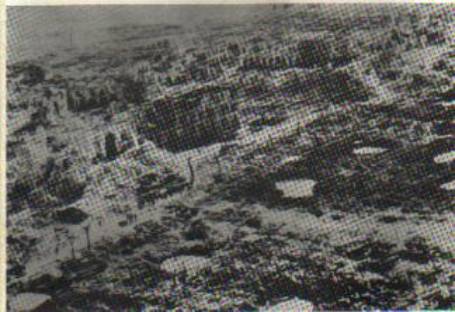
BIBLIOGRAFIA*
BOEMLER R., Monte Cassino, Castoldi e Baldini,
Milano 1964, Cassino, 1979
CHURCHILL WINSTON, Storia della seconda guerra mondiale,
Mondadori, 1965
DELLA SCIENZA ALIDA, Cassino nella bufera della 2ª
guerra mondiale, Tipografia Pontone
GROSSI TANCREDI, Il calvario di Cassino, Libreria
Lamberti editrice
HASSEL SVEN, Gli sporchi dannati di Cassino ,
Longanesi & C.
IZZI DE VINCOLIS MARIO, Ai margini della linea Gustav
Tipografia Pontone Cassino
Jadecola Costa, Vicende più o meno note verificatesi a
Roccasecca durante la seconda guerra Mondiale, Amministrazione comunale di
Roccasecca
Kesselring, memorie di guerra, Garzanti, Milano,
1954
LECCISOTTI T, Montecassino,Vallecchi, 1945
Liddel hart B.H, Storia militare della seconda guerra
mondiale, Mondadori
MORDAL, Cassino, Amiont dumont, Paris, 1952.
N.d.A.: Questo lavoro è debitore ai molti testi consultati
che ne hanno permesso la stesura: in particolare al volume di Alida Dell’Ascenza,
citato in bibliografia. Alcuni testi ivi citati non sono purtroppo reperibili
in commercio.