
Sito Promozionale di Cultura del Basso Lazio dell' Associazione onlus PRETA Via Sotto le mura snc - 03041 Alvito (FR) p.i. 02194120602
CIOCIARI.COM © pretaonlus 2000-2010 - ciociari @ pretaonlus.it



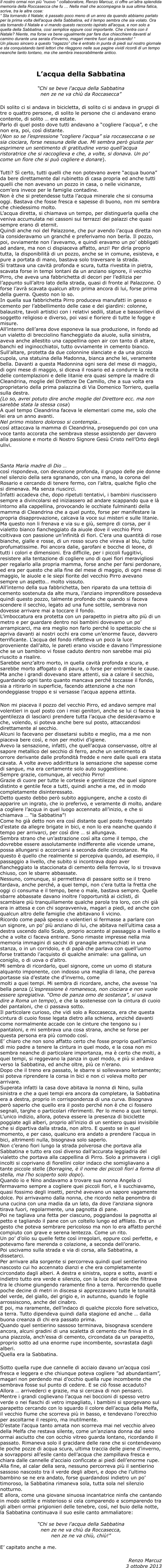
Il tempietto dedicato alla
Madonna di Lourdes
(anni 60)…
Le piccole stelle color indaco
Tommaso Pirro



Il tempietto nello stato attuale



Il laboratorio allo stato attuale.
(foto R. Tanzilli)

Maria Pia Pirro

nonna Angela

