Sito Promozionale di Cultura del Basso Lazio dell' Associazione onlus PRETA Via Sotto le mura snc - 03041 Alvito (FR) p.i. 02194120602
CIOCIARI.COM © pretaonlus 2000-2010 - ciociari @ pretaonlus.it

L’Eco di Roccasecca

Anno 19, n. 90
Aprile 2014





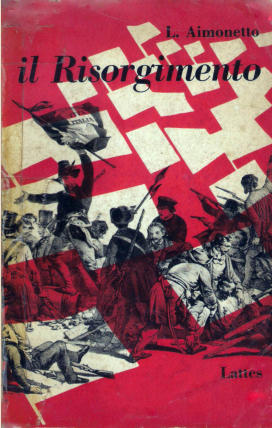
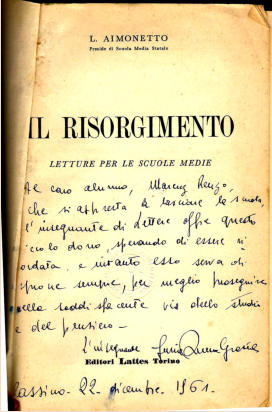


Graziella, Peppinella e... Peppantonio
Figure che nutrirono il mio spirito … e non solo!
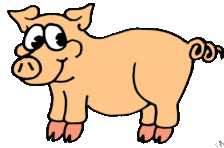
La copertina rossa
La sua dedica
Eccomi, all’epoca dell’asilo.
Quello di Roma, però. Poco
prima che ci trasferissimo a
Roccasecca
Si, è proprio lei,
la mia Maestra d’asilo
Peppantonio
L’asilo di Peppinella
La cara Professoressa Furia,
che i suoi amici chiamavano Graziella
