Io cercavo di tenermi il più lontano possibile e, senza
farmi vedere, puntavo anche un po’ i piedi sul
pavimento per non volare via come un foglio di
carta.
La valigia che avevamo con noi non era grande ma
pesava molto lo stesso ed era stretta da una cordicella
per evitare che le chiusure cedessero e si aprisse
all’improvviso. Era stata messa per terra, vicino al
corridoio che portava all’ufficetto dell’impiegato
postale.
Un tavolino con una sedia girevole, tutto di legno
chiaro e lucido e, attaccato ad una parete dove finiva
anche il tavolino, un classificatore, anch’esso di
legno chiaro e lucido, dove si smistavano le lettere e
le cartoline: questo era l’arredamento di
quell’ufficetto.
Una camicia bianca con relativo gilè nero, mezze
maniche anche nere ed una visiera senza cappello
attaccata alla fronte con un elastico, proprio come nei
film western: questo era l’abbigliamento di
quell’impiegato.
Lavorava ininterrottamente, con gli occhialetti sul
naso, a timbrare e a scrivere sui suoi registri, magari
imprecando quando c’era qualcosa che non andava.
Poi, ogni tanto, si fermava per accendersi una
sigaretta e scambiava qualche veloce battuta con
quegli altri che stavano nel bagagliaio discutendo
animatamente di tutto e di niente. A me lanciava
occhiate strane e mi sembrava non capisse che
diavolo ci stava a fare, quella mattina, un moccioso
sul suo bagagliaio, ma non mi disse nulla. Io, dal mio
angoletto, lo guardavo ingrugnito e con la testa un
po’ abbassata sperando solo che non mi buttasse
fuori dal portellone.
Papà se ne fregava, fumava e chiacchierava con gli
amici. Per farmi passare il tempo mi aveva comprato
un settimana enigmistica che avevo iniziato a fare
con una matita copiativa poggiandomi sul quel
tavolino pieno di vento. Ogni tanto qualcuno degli
amici di papà mi diceva, con accento ciociaro: “E’
pesante, eh?”, ma io non capivo.
Mi chiedevo perché mai quella specie di giornaletto
con scacchiere e qualche figura dovesse pesare più
degli altri mentre loro volevano solo dire che doveva
essere un po’ difficile da fare per un ragazzino della
mia età. Ma io proprio non li capivo.
Capitava anche che il treno entrasse in galleria e tutto
diventasse buio tranne l’ufficetto del postino che
timbrava e scriveva sui registri. Allora anche i grandi
tacevano, forse anche loro intimiditi dal frastuono che
il treno creava nella galleria e dal fumo della vaporiera
che entrava attraverso quel portellone aperto.
Il rumore era terrificante e invadeva il bagagliaio come
un demonio che dovesse terrorizzare le sue vittime
prima di carpirne una da portare via per sempre, prima
ancora che quell’antro d’inferno avesse termine. In quei
momenti cercavo tapparmi il più possibile le orecchie
con le mani e tenevo gli occhi chiusi per non vedere
nulla anche se intorno a me tutto era diventato nero
come la pece. Ogni tanto li aprivo sperando che la
galleria fosse finita ma vedevo solo le tracce rosse delle
sigarette che fumavano i grandi. Salivano e scendevano
in quel buio assordante e nient’altro. Tutto questo si
ripeteva ad ogni galleria e quando finivano papà mi
lanciava un’occhiata per vedere se c’ero ancora, poi
ricominciava a parlare con gli altri.
Finalmente arrivammo a Roma Termini mio padre
salutò il postino ed i suoi amici che scesero con un
salto dal portellone. Prese la valigia, mi diede la mano e
ce ne andammo verso la città. A questo punto, però,
tutto mi interessava un po’ meno frastornato com’ero
da quel viaggio così strano e così straordinario, con un
portellone aperto che ti poteva far volare via come un
foglio di carta.
Tutto sommato però mi era piaciuto, mi sembrava che
quell’esperienza mi avesse fatto diventare un po’ più
grande e forse era proprio così. L’avrei raccontata
senz’altro ai miei amici una volta tornato a Roccasecca
e l’avrei arricchita con mille particolari suggeriti da una
fantasia che faticavo a tenere a freno.
A mamma no, non avrei detto nulla, perché si sarebbe
dispiaciuta per tutta quell’aria e quel rumore.
Renzo Marcuz
… 2013
Immagine: dipinto di Teresa Puiatti
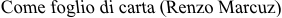



7
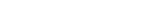
pag.2/2




