

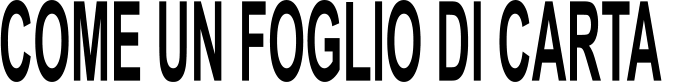
Avevo più o meno sette anni quando andai per la
prima volta a Roma a trovare gli zii che mi
avrebbero ospitato per qualche giorno e feci il
viaggio in treno, con papà. Era una splendida
mattinata di inizio estate e c’era voluto molto poco
per raggiungere la stazione dal palazzo dei
ferrovieri di Roccasecca Scalo, dove abitavo con la
mia famiglia. Era infatti bastato traversare un
giardinetto su cui affacciavano le finestre del
nostro appartamento, scendere due scalette fatte
“alla benemmeglio” con traverse di legno delle
ferrovie, superare un binario dove si fermavano
sempre le locomotive a vapore per rifornirsi di
acqua ed a pulire la caldaia, passare vicino ad un
fabbricatino dell’Ufficio IES Impianti Elettrici e
Segnalamento dove gli operai mettevano le batterie dei
treni per farle ricaricare, ed eravamo in stazione .
Sembra molto ma in realtà era pochissimo.
Il treno che ci avrebbe portati a Roma veniva da
Cassino e si capiva che stava per arrivare dal trillo
forsennato di una campanella d’ottone attaccata al
muro vicino all’ufficio del Capostazione. Poi,
quando si acchetava, veniva spontaneo guardare
nella direzione da dove lo aspettavamo.
Si vedeva all’inizio solo uno sbuffo di fumo bianco
che saliva verso il cielo, poi diventava sempre più
grande e sempre più bianco finché cominciava a
distinguersi anche la locomotiva, nera e lucida.
Quindi si riconosceva tutto il treno che arrivava in
stazione sferragliando e alla fine si fermava con
uno grande stridore di freni. Allora le porte delle
carrozze si aprivano e la gente saliva e scendeva
contenta, con le mamme che prendevano in braccio
i bambini e i ragazzi che scappavano via di corsa.
Durante la sosta quella locomotiva così nera e così
lucida faceva un rumore strano, metallico, che
pareva quasi una canzone:
Da-dan da-dan
Da-dan da-dan
Da-dan da-dan
era il suono e sembrava che la grande macchina
fosse un essere come tutti gli altri che doveva
riprendere un po’ di fiato prima di lanciarsi
nuovamente nella folle corsa verso la stazione
successiva.
Intanto il macchinista e il fuochista controllavano
tutto affinché quel mostro metallico, straordinario
ed obbediente, potesse ripartire puntuale al loro
comando.
Mi sembravano uomini coraggiosi, orgogliosi e
contenti del loro lavoro, che curavano la loro
locomotiva più e meglio di qualsiasi altra cosa al
mondo. Era gente capace di far andare il treno con
qualsiasi caldo e con qualsiasi freddo e durante tutto
il tempo in cui il convoglio correva sulle rotaie
divorando le distanze il macchinista guardava
lontano i segnali ferroviari socchiudendo gli occhi
per vedere bene, senza sbagliarsi mai.
Intanto il fuochista caricava carbone nella fornace
ardente, palate su palate, ma non mollava. Poi,
quando si fermavano nella stazione, allora potevano
rilassarsi un attimo e i loro volti si distendevano.
Quello del macchinista era annerito dal fumo ma
vicino agli occhi che aveva socchiuso per vedere
meglio la pelle era rimasta bianca e sembrava che il
suo viso fosse come tatuato, con quelle linee chiare
che si erano formate. Quello del fuochista era pure
lui annerito ma un po’ più stanco ed anche rosso per
la fatica e la vicinanza alla fornace che aveva
alimentato a forza di braccia, senza smettere mai .
Io e papà eravamo quindi saliti su quel treno che ci
avrebbe portati a Roma e l’avevamo fatto dopo
avere salutato per l’ultima volta mamma, da
lontano, poco prima di voltare l’angolo dell’Ufficio
IES.
Avevamo preso posto nel bagagliaio postale, una
carrozza diversa dalle altre, messa proprio all’inizio.
Era infatti agganciata al tender nero della
locomotiva, quello che portava il carbone, e dentro
c’erano due o tre ferrovieri oltre ai postini; mio
padre aveva visto alcuni suoi amici e voleva parlare
con loro.
Questa strana carrozza, come oggi non se ne vedono
più, aveva, come caratteristica particolare, un
finestrino sporgente da dove l’addetto al servizio
postale poteva guardare lungo le fiancate di tutto il
treno. Riusciva così a capire dove si trovava il
collega che lo aspettava con il carrettino sui
marciapiedi delle stazioni e chiamarlo per caricare
e scaricare. Tutto questo mi ricordava le scene dei
film western che si proiettavano il sabato sera a
Roccasecca in un Magazzino Merci dello Scalo
ferroviario proprio vicino alla stazione, poco oltre il
Dopolavoro.
Anche il posto dov’ero seduto io era strano: un
grande locale vuoto con qualche scatolone messo da
un lato ed alcuni sacchi di iuta con dentro le lettere
un po’ afflosciati per terra, pronti per essere scaricati
alle stazioni dove il treno si sarebbe fermato.
I pochi sedili disponibili erano attaccati alle pareti e
per sedere si doveva abbassarli.
Mio padre parlava con i suoi amici postini ed io me
ne stavo rannicchiato su uno di questi sedili strani e
mi appoggiavo su di un tavolino che era stato aperto
davanti a me, anche questo curioso perché si alzava
e si abbassava.
Ascoltavo quello che i grandi dicevano mentre
guardavo fuori attraverso un portellone scorrevole
che era rimasto aperto. Era enorme, andava dal
pavimento al soffitto e non c’era nulla che
impedisse di essere trascinati via dal vento, solo una
sbarra orizzontale a metà altezza che quando il treno
si fermava ad una stazione veniva sollevata per
caricare o scaricare i pacchi.
(di Renco Marcuz)


6

pag.1/2




